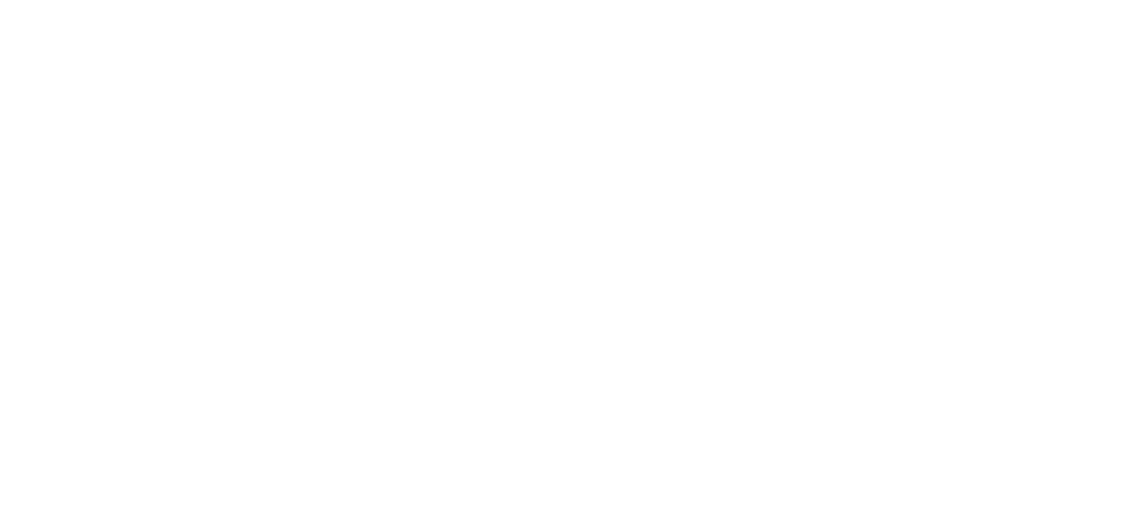La ricerca sul cancro è un lavoro di squadra. Nessun laboratorio, da solo, ha tutte le competenze, le tecnologie o i finanziamenti per trasformare una scoperta iniziale in una terapia reale. Ed è proprio per questo che la collaborazione tra università e aziende farmaceutiche è diventata una componente essenziale dei progressi in oncologia.
Nei laboratori universitari nascono molte delle idee che poi diventano la base dei nuovi trattamenti: ricercatori che studiano come si comportano le cellule tumorali, quali meccanismi usano per crescere o per sfuggire ai farmaci. Dall’altra parte, aziende come AstraZeneca hanno la possibilità di trasformare queste intuizioni in farmaci veri, testandoli in grandi studi clinici e portandoli fino all’approvazione.
Un esempio molto rappresentativo di come questi due mondi si completino arriva dalla rete internazionale di collaborazioni costruita da AstraZeneca negli ultimi anni. Uno dei risultati più significativi nasce dal lavoro con il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Grazie alla condivisione dei dati del database MSK‑IMPACT, che raccoglie informazioni genetiche di circa 7.000 pazienti oncologici, è stato possibile capire meglio come alcuni tumori al seno ER+ (estrogen‑receptor positive), cioè tumori che crescono in presenza di estrogeni, diventano resistenti alle terapie ormonali. Questo tipo di resistenza è uno dei motivi principali per cui i trattamenti perdono efficacia nel tempo. Analizzando insieme questi dati, ricercatori accademici e scienziati dell’azienda hanno identificato nuovi meccanismi che potrebbero spiegare il fenomeno, aprendo la strada a strategie più mirate.
Un altro esempio arriva dalla collaborazione con il Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO) di Barcellona. Qui è stato studiato RAD51, un biomarcatore, cioè un segnale biologico che aiuta a prevedere come si comporterà un tumore, che si è rivelato utile per capire se un paziente risponderà o meno a certe terapie che agiscono sui meccanismi di riparazione del DNA. I ricercatori hanno osservato che livelli elevati di RAD51 possono indicare una maggiore resistenza ai trattamenti. Questo significa poter evitare terapie inefficaci e orientare i pazienti verso alternative più promettenti.
Questi risultati non rimangono chiusi nei laboratori. Hanno un impatto concreto sulla vita dei pazienti: aiutano a scegliere il trattamento più adatto, riducono gli effetti collaterali evitando terapie inutili e accelerano l’arrivo di nuove cure più efficaci.
L’oncologia è probabilmente uno dei campi dove la collaborazione tra accademia e industria ha dato i frutti più evidenti. Molte delle terapie che oggi consideriamo “standard”, come le terapie mirate o l’immunoterapia, sono nate proprio dalla combinazione tra l’intuizione accademica e la capacità industriale di trasformarla in realtà.
E mentre questa collaborazione continua a evolversi, una cosa è chiara: il futuro delle cure oncologiche sarà sempre più personalizzato, preciso e costruito sull’unione di competenze diverse.